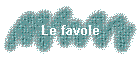|
La leadership ed il potere |
Favola di Esopo n. 237
I topi e le donnole
Era scoppiata la guerra tra i topi e le donnole. I topi che venivano sempre sconfitti, fecero una riunione tutti insieme e conclusero che la causa dei loro insuccessi era la mancanza di un capo. Di conseguenza, dopo aver scelto alcuni di loro, per alzata di mano li nominarono strateghi. Costoro, per distinguersi dagli altri, fabbricarono delle corna e se le applicarono. Ma, quando divampò la battaglia, i topi, sbaragliati in massa, cercarono rifugio nei buchi e, mentre tutti gli altri vi si insinuarono facilmente, i capi non riuscirono a infilarsi per colpa delle corna. E così vennero catturati e divorati. Nello stesso modo la vanagloria è per molti fonte di guai”.
Questa favola ci permette di andare, immediatamente, al “core” della leadership, che non significa mettersi i galloni da capo ma assumersi la responsabilità di attivare quel processo con il quale, esercitando la funzione di “guida”, s’influisce sulle attività degli individui, singolarmente o in gruppo, sviluppando un’azione di persuasione e di spinta al lavoro per il conseguimento degli obiettivi comuni.
Essere leader significa avere un’attitudine ad indirizzare gli altri, possedere le conoscenze delle specifiche tecniche manageriali e le capacità di renderle operative, il tutto supportato da esperienze formative che abbiano inciso positivamente sul sistema di convinzioni riguardante il proprio valore, l’autoefficacia personale ed il rispetto verso i propri collaboratori.
Il risultato è una persona competente con un atteggiamento aperto, propositivo e responsabile, con un orientamento ai comportamenti efficaci, che sa farsi seguire nei percorsi intrapresi e sa “utilizzare i talenti” delle persone.
Una delle prime cose da analizzare sul tema della leadership è il risultato dell’incrocio tra le variabili “autorità” ed “autorevolezza”, considerata la prima come riconoscimento di un potere che viene dall’alto, e la seconda come riconoscimento di un potere che viene dal basso, dalla base come si usava dire qualche tempo fa.
Si hanno, in questo
modo, quattro quadranti (figura 4 di pagina 104):
“Il primo è quello contrassegnato dalla lettera A, dove un’alta autorità
s’incrocia con l’assenza di autorevolezza, e sta a definire il momento in
cui la leadership viene affidata ad un “capo gerarchico” che, se non riesce
a sviluppare una dimensione di guida e di supporto nei confronti dei
collaboratori, si trova a competere con la leadership “vera e reale”
esercitata da un antagonista, rappresentata nel quadrante opposto C, dove il
leader è senza autorità formale, ma con una forte e riconosciuta
autorevolezza.
La presenza, contemporaneamente, di alta autorità ed alta autorevolezza, coniugando carisma personale, competenze e ruolo aziendale, esprime la dimensione di “leader gerarchicamente riconosciuto” che occupa il quadrante B, quello auspicato in tutte le organizzazioni, all’opposto del quadrante D, che esprime la “triste” situazione, in termini aziendali, dell’individuo senza autorità né autorevolezza, definibile “uno fra tanti”.
Alla luce di quanto osservato, assumere il ruolo di capo presuppone la conoscenza del contesto nel quale si lavora, la fiducia nelle proprie competenze e la consapevolezza del proprio atteggiamento nei confronti dei collaboratori.
Dietro, infatti, le tipologie di gestione della leadership c’è il proprio sistema di convinzioni che può esprimersi attraverso una gestione di tipo autoritario, con una supervisione rigida ed un controllo continuo dei lavoratori, considerati in genere poco propensi all’impegno, ovvero una leadership partecipativa, fondata su relazioni positive di accettazione e scambio.
Due visioni polarizzate che nascondono due modi di pensare, o come si definiscono in psicoterapia, due “assunti di base” opposti ed antitetici, rappresentati in modo efficace da Douglas McGregor, esperto americano di management, attraverso la teoria X e la teoria Y.
La prima evidenzia l’atteggiamento del capo verso i collaboratori che ritiene che abbiano un'avversione naturale per il lavoro e cerchino, quindi, di evitarlo non appena sia loro possibile.
Per ottenere i risultati auspicati dall’azienda, quindi, devono essere guidati, controllati e, perfino, minacciati di punizioni, poiché cercano di evitare le responsabilità, essendo poco ambiziosi e desiderando, soprattutto, la sicurezza.
Tutt’altra cosa è avere a che fare - la cosiddetta teoria Y - con un atteggiamento del capo che ritiene i suoi collaboratori naturalmente interessati al lavoro, all’assunzione di responsabilità, capaci di esercitare un autocontrollo per raggiungere gli obiettivi in cui si sentono coinvolti e per i quali sono disposti ad un impegno serio e motivato.
A questo proposito, una mia recente esperienza in un’aula di formazione può offrire un contributo a questo tema.
“Era un corso per dirigenti pubblici sul tema della gestione dei propri collaboratori e si lavorava sulle convinzioni di ciascuno sul piano della fiducia e del conseguente utilizzo della delega, sviluppando un’esercitazione sul proprio livello d’ansia nel sapere l’ufficio privo della loro guida.
Le risposte furono le più svariate: quello che caratterizzava la discussione erano le precedenti esperienze che avevano vissuto in situazioni similari e che incidevano sulla convinzione del momento.
Una dirigente, affermando la propria fiducia nei collaboratori e nella funzionalità dell’organizzazione, sottolineò nel suo intervento che le cose andavano bene grazie all’autonomia operativa che avevano acquisita, che a volte la facevano sentire quasi superflua.
Nel coffee break successivo, la citata dirigente ricevette una telefonata che l’informava di un evento non favorevole avvenuto alla struttura immobiliare, fortunatamente senza conseguenze per le persone, al quale i suoi delegati avevano fatto fronte in modo efficace e risolutivo, per cui la comunicazione aveva solo un carattere informativo.
E la dirigente rimase in aula l’intera giornata”.
La domanda che, immediatamente, “rimbalzò” tra i colleghi presenti in aula, dopo essere venuti a conoscenza del caso, riguardava che tipo di persona fosse la collega: una tendenziale incosciente o invece, soltanto fortunata nell’avere un gruppo di collaboratori particolarmente efficaci o, forse, era proprio un capo con una “performante” competenza nella leadership.
Nei nostri atteggiamenti, purtroppo, c’è un proverbio che rinforza il sistema di convinzioni legato alla teoria X: “Quando il gatto non c’è, i topi ballano” e così, in vari uffici, ho potuto osservare atmosfere rilassate e distese quando il capo era in una riunione fuori sede.
Il capo, nell’affrontare i problemi e trovare le necessarie soluzioni, può, dunque, dare uno spazio ai suoi collaboratori che va da un minimo ad un massimo:
“Si parte dal “comando”, quando gestisce il problema e comunica esclusivamente la soluzione da lui trovata, ovvero può operare attraverso la “persuasione”, quando vende ai collaboratori la soluzione presa in modo di dargli l’impressione di essere in qualche modo anche loro autori della scelta.
Può sviluppare il “confronto” quando mantiene la sua autonomia nell’individuare il problema e discute soltanto la soluzione, o, ancora, può attivare la “partecipazione” nel trovare la soluzione stimolando ed accettando i loro suggerimenti.
Il capo opera un “coinvolgimento”, quando lascia ai collaboratori la soluzione del problema da lui individuato, e, infine, si arriva alla “responsabilizzazione”, quando offre la delega sia per l’individuazione del problema che per la sua soluzione”.
In tema di leadership ci sono diverse teorie che cercano di definire il capo “ideale” in modo assoluto, ma nessuna può prescindere dalla necessaria attenzione che deve avere chi gestisce collaboratori a sviluppare un processo di consapevolizzazione di sé, delle proprie aspettative su quelli che dirige, operando un’attenta valutazione degli stessi e, soprattutto, un monitoraggio dei processi di cambiamento intervenuti ed in corso, per non cadere nell’errore di essere condizionato nel proprio sistema di convinzioni dai pregiudizi o dai giudizi precedenti.
Si deve, dunque, lavorare sulla propria professionalità e sulla motivazione per diventare un capo con la “C” maiuscola, capace di indirizzare e dirigere con la “mente” e con il “cuore”, come dice il già citato Daniel Goleman trattando dell’intelligenza emotiva, per riuscire a produrre, nell’ambiente nel quale esercita la propria autorità, “benessere” per sé e gli altri.
In una tale ottica, una visione completa
della leadership, ci può essere utile riflettere sulla matrice di Blacke e
Mouton, la classica “managerial grid” (figura 5 di pagina 105), che incrocia
l’orientamento del capo verso i
collaboratori con l’orientamento ai risultati:
“Si può avere un atteggiamento “paternalista”, con un alto livello di
orientamento verso i collaboratori e un basso livello verso i risultati
(quadrante A), dove il “focus” dell’attenzione è sulle esigenze delle
persone e sul creare rapporti soddisfacenti e clima positivo, all’opposto c’è
un atteggiamento “autoritario/direttivo”, basso orientamento ai
collaboratori ed alto ai risultati, dove il focus
è esclusivamente sull’efficienza operativa e su un’efficace
produttività (quadrante C).
L’atteggiamento “partecipativo”, con un alto orientamento ai collaboratori e, contemporaneamente, ai risultati ha il suo focus sullo sviluppo di decisioni condivise e sul coinvolgimento di tutti nel realizzare gli obiettivi aziendali (quadrante B) ed all’opposto c’è l’atteggiamento “laissez faire” dove il “focus” è su una sorta di abdicazione nell’esercizio della leadership, efficace scelta a fronte di collaboratori autonomi e motivati, un po’ meno in presenza di persone non preparate e bisognose di essere indirizzate (quadrante D).
Al centro, poi, c’è un atteggiamento di sintesi e di mediazione, in cui il capo è una sorta di “mediatore” che si orienta in modo flessibile in funzione dell’ambiente e delle situazioni.
La ricerca della consapevolezza del proprio atteggiamento di leadership dovrebbe realizzarsi attraverso l’ascolto dei feed back provenienti dai propri collaboratori, che sono utili momenti di verifica dei propri comportamenti.
Senza andare all’applicazione di metodi di “upward evaluation”, vale a dire di formali valutazioni fatte dai collaboratori sui capi, è necessario entrare in relazione con loro ed osservare la realtà organizzativa dal loro punto di vista, proprio perché “il principio primo della consapevolezza è la conoscenza”, e così si può evitare di sbagliare.
Si potranno, così, contemperare i propri atteggiamenti con gli atteggiamenti delle persone con le quali si lavora, arrivando ad esercitare una leadership più flessibile ed “ecocompatibile” con il sistema di riferimento.
Mi sono posto per anni il problema se il collaboratore dovesse adattarsi al capo o il capo, al contrario, dovesse cercare di orientarsi verso le diverse tipologie dei collaboratori, seguendo le teorie di una leadership “situazionale” o, come alcuni autori la definivano, “trasformazionale”: con una battuta “da uomo per tutte le stagioni a capo per tutti i collaboratori”.
La risposta sta nella convinzione di ciascun capo della necessità di sviluppare una precisa competenza di leadership che significa assumersi la responsabilità di “incidere” positivamente sugli altri: ogni lavoratore, infatti, ha avuto un “imprinting” dal suo primo capo che può averlo condizionato, in positivo o in negativo, tutta la vita lavorativa.
Solo così potrà agire in modo efficace, nonostante lo scarso tempo a disposizione, esercitando il comando di fronte ad una situazione d’emergenza, aiutando il collaboratore in difficoltà e supportandolo nel raggiungimento dell’obiettivo o, infine, dandogli la delega, al momento opportuno, per farlo crescere ed assumersi nuove responsabilità.
Ultimamente si è parlato molto di leader che deve diventare “coach”, allenatore e facilitatore dei processi d’apprendimento del gruppo, che riesce ad incidere sulle persone per far loro capire il senso della “squadra”, dove si perde l’individualità soggettiva a vantaggio del “team” che acquista, in questo modo, una sua nuova identità capace di raggiungere risultati positivi inaspettati, come accade nel mondo sportivo, pieno d’esempi del genere.
Il leader deve essere soprattutto una “persona responsabile”, che si rispetta e rispetta gli altri, che sa contemperare le sue esigenze, quelle aziendali e quelle dei suoi collaboratori: un po’ comandante, un po’ “coach”, un po’ “counselor”, nel senso di consigliere sempre pronto ad aiutare le persone bisognose di comprensione, un po’ “mentore”, nel senso di essere il punto di riferimento nelle situazioni importanti come l’educatore di Telemaco, il figlio di Ulisse, e, infine, un po’ “visionario”, nel senso di avere una chiara “vision” futura dell’organizzazione verso la quale condurre la sua squadra con determinazione ed umanità.
Uno spunto conclusivo va fatto sul collegamento tra la leadership ed il potere, parola quest’ultima evocatrice di abusi e di prevaricazioni, mentre l’etimologia sta ad evidenziare, soprattutto, l’opportunità di agire in quanto “potens”.
Il potere, che è la facoltà di influire sulle persone sugli eventi e sulle decisioni, si può articolare nel potere di premiare o di punire, nel potere di controllare le informazioni, nel potere di competenza, in base alla sua preparazione e professionalità, nel potere di referenza, in base al suo carisma riconosciuto e, infine, nel potere legittimo derivante da valori interiorizzati che riconoscono al capo, che ha ricevuto una tale investitura, il diritto di comandare e d’incidere sui “subordinati”.
Uno spunto su cui riflettere è che sugli strumenti elettronici il tasto che li fa accendere e funzionare si chiama “power”, traduzione nella lingua inglese del sostantivo “potere” che si differenzia dal verbo che si traduce, invece, “can” o “may”, a seconda se l’azione dipende dalla volontà propria o altrui.
In italiano, il verbo potere, invece, si suddivide in tre gruppi di significati (da avere la possibilità a riuscire a fare) che si articolano a loro volta in circa una ventina di espressioni, mentre il sostantivo ha una decina di contenuti semantici (da capacità a proprietà di un corpo), in più, il collegamento della parola potere con delle preposizioni fa assumere ulteriori valori: diverso è, infatti, esprimere il concetto riguardante “il potere di o per fare” rispetto a “il potere su qualcuno”.
Bisogna, dunque, verificare le modalità
d’utilizzo del potere che può essere usato a vantaggio dell’organizzazione
e non esclusivamente per se stessi, rendendolo più ampio ed efficace attraverso
il coinvolgimento e la partecipazione degli altri e creando quella dimensione
positiva che è scritta su una targa trovata nella scuola militare della "Nunziatella"
di Napoli:
"Nella casa del giusto anche coloro che esercitano un comando non fanno in
realtà che prestare un servizio. A coloro cui sembrano comandare, essi, di
fatto, non comandano per cupidigia di dominio ma per dovere di fare del bene
agli uomini; non per orgoglio di primeggiare ma per amore di provvedere".